Tre famiglie turche, nessun legame di parentela, stessa condanna genetica. I bambini nascono sordi, il mondo resta muto. Per decenni la diagnosi è stata una sentenza senza appello: sordità congenita neurosensoriale, ereditaria, irreversibile. Poi qualcuno ha guardato più da vicino e ha trovato un gene, il CPD, che in teoria serve per altre cose ma nell’orecchio interno ha un ruolo preciso. Quando si rompe, le cellule ciliate della coclea muoiono per stress ossidativo.
Il motivo? Manca arginina, manca ossido nitrico, manca il segnale chimico che tiene in vita quelle cellule microscopiche che traducono le vibrazioni sonore in impulsi nervosi. La scoperta, pubblicata sul Journal of Clinical Investigation, non si ferma alla diagnosi. I ricercatori hanno testato due strategie terapeutiche.
Sordità congenita, il gene che nessuno cercava
Il team guidato da Rong Grace Zhai dell’Università di Chicago e Mustafa Tekin dell’Università di Miami ha identificato mutazioni rare nel gene CPD (carbossipeptidasi D) in cinque individui provenienti da tre famiglie turche senza legami di parentela. Tutti presentavano sordità congenita diagnosticata in età precoce. Il gene CPD appartiene a una famiglia di enzimi che modificano le proteine tagliandone le estremità. È attivo in tutto l’organismo, ma il suo ruolo nell’udito era sconosciuto.
Quando i ricercatori hanno ampliato la ricerca attraverso il 100,000 Genomes Project britannico, hanno scoperto che altre persone con mutazioni del gene CPD mostravano segni di perdita uditiva precoce, rafforzando il legame tra questo gene e la funzione uditiva. In Italia, circa un neonato ogni 1.000 nasce con una forma di sordità congenita, e nel 60% dei casi la causa è genetica.
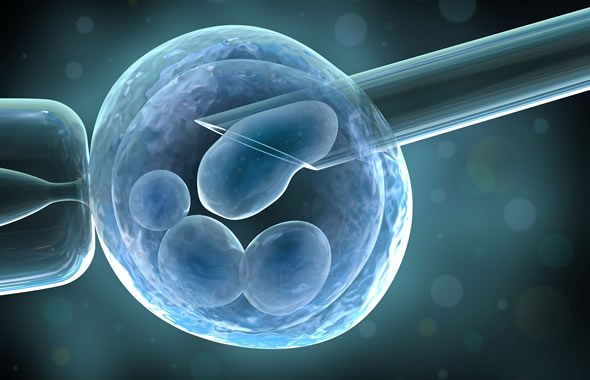
Come funziona il meccanismo
Per capire come il gene CPD influenzi l’udito, i ricercatori hanno condotto esperimenti su topi. Normalmente, il gene CPD codifica per un enzima che produce l’amminoacido arginina, che a sua volta genera ossido nitrico, un neurotrasmettitore fondamentale per la segnalazione nervosa. Nell’orecchio interno, le mutazioni del gene CPD interrompono questo processo, innescando stress ossidativo e morte delle delicate cellule ciliate sensoriali che rilevano le vibrazioni sonore.
“Abbiamo scoperto che il CPD mantiene il livello di arginina nelle cellule ciliate per consentire una rapida cascata di segnalazione generando ossido nitrico”, ha spiegato Zhai. “Ecco perché, sebbene sia espresso ubiquitariamente in altre cellule del sistema nervoso, queste cellule ciliate in particolare sono più sensibili o vulnerabili alla perdita di CPD“.
Le cellule ciliate della coclea sono strutture estremamente delicate. Quando il gene CPD smette di funzionare, i livelli di arginina, ossido nitrico e cGMP (guanosina monofosfato ciclica) nelle cellule dei pazienti diminuiscono, portando a stress ossidativo e morte cellulare attraverso meccanismi mediati dallo stress del reticolo endoplasmatico.
Il silenziamento del CPD in colture di coclea di topo ha portato ad un aumento dell’apoptosi.
La terapia per la sordità congenita che funziona sui moscerini
I ricercatori hanno usato anche i moscerini della frutta come modello per studiare gli effetti delle mutazioni CPD. I moscerini privi del gene CPD mostravano comportamenti coerenti con danni all’orecchio interno, come perdita dell’udito e problemi di equilibrio. A questo punto il team ha testato due approcci per trattare il problema: integratori di arginina per compensare quella persa a causa della mutazione, e sildenafil (il principio attivo del Viagra), un farmaco che stimola uno dei percorsi colpiti dalla riduzione dell’ossido nitrico.
Entrambi i trattamenti hanno migliorato la sopravvivenza cellulare nelle cellule derivate dai pazienti e ridotto i sintomi di perdita uditiva nei moscerini della frutta. I moscerini trattati con L-arginina o sildenafil hanno mostrato comportamenti migliorati, riflettendo un parziale ripristino della funzione uditiva.
Non è la prima volta
Questa non è la prima volta che la terapia genica mostra risultati promettenti contro la sordità congenita. Nel 2024 una bambina di nome Opal, nata sorda a causa di una mutazione nel gene OTOF (otoferlina), aveva riacquistato l’udito grazie a una terapia sperimentale chiamata DB-OTO. In quel caso, il trattamento consisteva nell’inserire una copia sana del gene in un virus inerte, poi iniettato nella coclea. Anche quella mutazione, come il CPD, riguarda una proteina coinvolta nella comunicazione tra l’orecchio interno e il cervello.

Cosa significa per i pazienti
“Ciò che rende questo davvero significativo è che non solo comprendiamo il meccanismo cellulare e molecolare sottostante per questo tipo di sordità, ma abbiamo anche trovato una promettente via terapeutica per questi pazienti”, ha dichiarato Zhai.
“È un buon esempio dei nostri sforzi per riutilizzare farmaci approvati dalla FDA per il trattamento di malattie rare”.
Sebbene lo studio si sia concentrato su individui con una rara combinazione di mutazioni del gene CPD, potrebbero esserci implicazioni più ampie se singole mutazioni fossero collegate alla perdita uditiva legata all’età. I ricercatori prevedono di continuare a studiare come funziona la segnalazione dell’ossido nitrico nel sistema sensoriale dell’orecchio interno e di indagare quanto siano comuni le mutazioni CPD in popolazioni più ampie.
“Quante persone portano varianti in questo gene e c’è una suscettibilità alla sordità o alla perdita dell’udito dipendente dall’età?”, si chiede Zhai. “In altre parole, è questo un fattore di rischio per altri tipi di neuropatia sensoriale?”
La domanda resta aperta, ma la scoperta pubblicata su ScienceDaily rappresenta un passo avanti significativo nella comprensione delle basi genetiche della sordità congenita.
A differenza della maggior parte delle forme genetiche di perdita uditiva, considerate irreversibili, questo studio dimostra che interventi semplici come integratori alimentari di arginina o farmaci che potenziano la segnalazione del cGMP possono ripristinare funzioni cellulari chiave e ridurre la morte cellulare. I test genetici potrebbero aiutare a identificare chi potrebbe beneficiarne, aprendo la strada a cure più personalizzate ed efficaci.
Sono necessari ulteriori studi, inclusi trial clinici e test più estesi sugli animali, ma la scoperta di un percorso trattabile per la perdita uditiva ereditaria è un progresso importante. Per ora, resta una domanda.
Se la mutazione CPD è più comune di quanto pensassimo, quante persone con problemi di udito potrebbero trarre beneficio da una semplice integrazione? La risposta potrebbe arrivare presto.


