Sono passati 134 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII, l’enciclica che rispose alla prima rivoluzione industriale riaffermando la dignità del lavoro umano. Oggi, con l’intelligenza artificiale che potrebbe sostituire non solo le braccia ma anche le menti, il suo “erede ideologico”, Leone XIV, si propone di difendere quei valori. Robert Prevost, matematico oltre che religioso, porta sul soglio pontificio una sensibilità rara verso la tecnologia: né tecnofobia né tecnofilia acritica, ma la consapevolezza che gli algoritmi possono essere strumenti di libertà o di oppressione.
“L’intelligenza artificiale comporta nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”, ha dichiarato Leone XIV nel suo primo incontro con i cardinali. Parole che preannunciano un pontificato in prima linea sul fronte della rivoluzione digitale.
Leone XIV e la sfida etica nell’era dell’algoritmo
La scelta del nome Leone, i media ce lo hanno fatto sapere in tutte le salse, non è casuale per il primo Papa statunitense della storia. Con questo gesto simbolico, ha tracciato un parallelo chiaro tra la prima rivoluzione industriale affrontata da Leone XIII e la (molto) prossima rivoluzione digitale. Se la Rerum Novarum del 1891 mise al centro la dignità del lavoro in un’epoca di sfruttamento, oggi l’ipotizzata “Rerum Digitalium” potrebbe rappresentare la bussola etica nell’era dell’automazione e degli algoritmi.
L’approccio di Leone XIV si inserisce in una linea di continuità con il suo predecessore. Papa Francesco aveva già posto l’attenzione su questi temi, in particolare durante il suo storico intervento al G7 di giugno 2024 dove aveva lanciato un monito inequivocabile: “L’umanità è senza speranza se dipenderà dalla scelta delle macchine”. Francesco aveva evidenziato come nessuna innovazione finisca per essere neutrale, perché ogni tecnologia porta con sé una visione del mondo e struttura di potere.
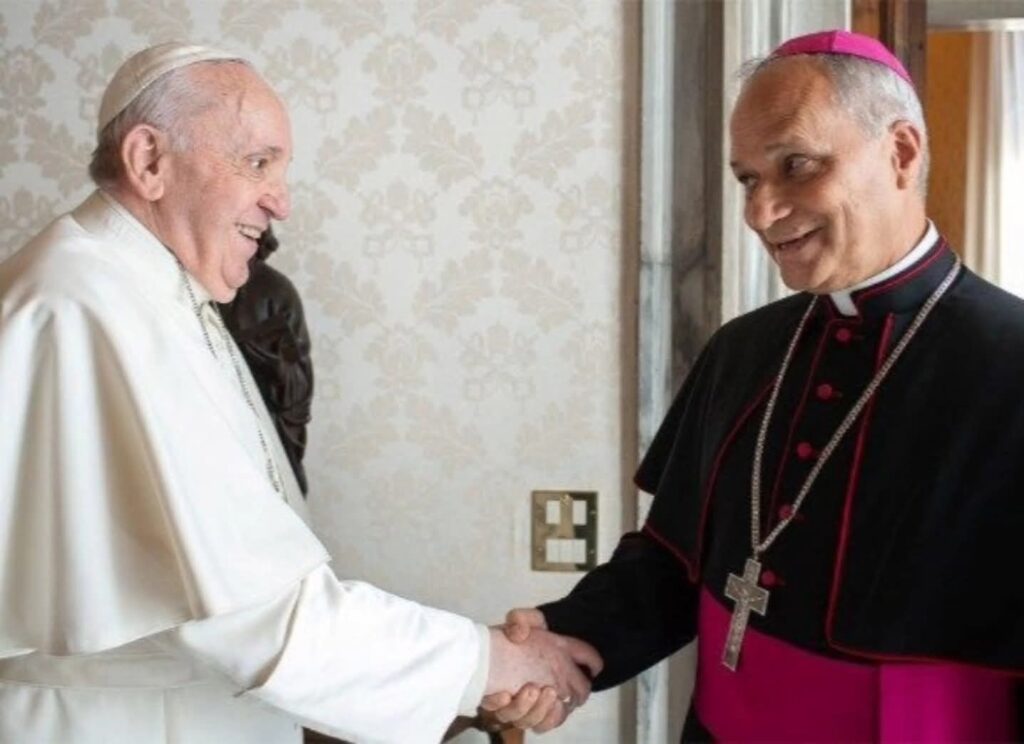
Un ponte tra fede e scienza
Il percorso di Leone XIV sembra quasi predestinato a questo compito: una laurea in matematica prima di entrare nell’ordine agostiniano, un’esperienza pastorale tra Nord e Sud America, e una sensibilità particolare verso le questioni sociali. Questa formazione interdisciplinare gli permette di parlare con autorevolezza di tecnologia senza cedere né al facile entusiasmo né alla condanna aprioristica.
In questo suo cammino, il Pontefice può contare su figure che hanno già tracciato sentieri importanti nel dialogo tra etica e intelligenza artificiale. Tra questi spicca Padre Paolo Benanti, francescano e ingegnere, nominato dal governo italiano presidente della Commissione sull’intelligenza artificiale e consulente del Vaticano sulle questioni digitali. Benanti siede anche nella commissione ONU per l’etica digitale, incarnando quel ponte tra religione e tecnologia che Leone XIV sembra voler rafforzare. Ci riuscirà?
Leone XIV e la strada (in salita) verso un “nuovo umanesimo digitale”
La visione che potrebbe emergere dal pontificato di Leone XIV si orienta verso quello che alcuni commentatori hanno definito un “nuovo umanesimo digitale”. Non si tratta di rifiutare l’innovazione tecnologica, ma di guidarla verso un modello di sviluppo che metta al centro la persona umana, la cooperazione globale e la sostenibilità.
Il rischio maggiore che il Pontefice intravede è quello di una dipendenza eccessiva dai mezzi dell’intelligenza artificiale, che “potrebbe ridurre la capacità umana di decisione autonoma e di azione responsabile”. Un timore già espresso nella nota vaticana Antiqua et Nova, pubblicata a gennaio 2025, che sottolineava come la dignità umana non possa essere ridotta a un insieme di dati.
Le sfide concrete
Nel nostro quotidiano, l’intelligenza artificiale solleva già questioni etiche urgenti: chi è responsabile quando un algoritmo discrimina o danneggia qualcuno? Come proteggere i lavoratori sostituiti dall’automazione? In che modo garantire che le decisioni cruciali restino sotto controllo umano?
Leone XIV sembra particolarmente attento a questa dimensione concreta, allontanandosi da discussioni teoriche per toccare il cuore delle preoccupazioni delle persone comuni. In un’epoca in cui l’IA può licenziare, assumere o escludere individui, diventa fondamentale stabilire limiti etici chiari e riaffermare il primato dell’umano.
La sfida che il Papa lancia non è solo pastorale, ma profondamente politica nel senso più nobile del termine: una chiamata a ripensare le basi della giustizia sociale nell’era digitale, dove la tecnologia sia strumento di liberazione e non di oppressione. È una strada, lo sapete, complicatissima e non scontata: un progetto più destinato a fallire che a riuscire. Vedremo se il matematico nato a Chicago e diventato erede di Pietro riuscirà a lastricarne almeno un pezzo, perché forse mai come oggi la religione può rappresentare un contrappeso importante alla disumanità, anche per chi non crede.


