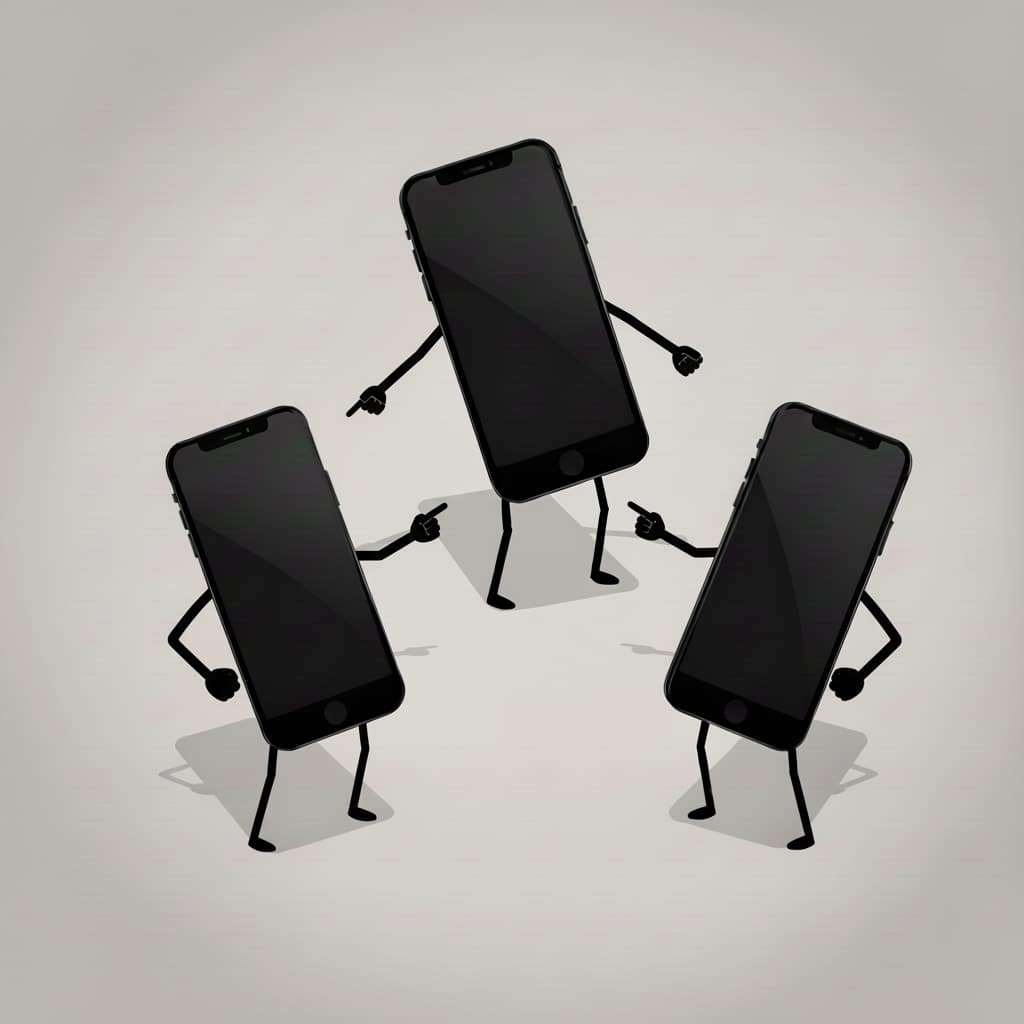C’è stato un momento preciso, da qualche parte tra il 2007 e il 2015, in cui l’elettronica ha perso i colori. Non è successo tutto insieme. Prima sono spariti i pulsanti colorati. Poi le forme curve. Poi i LED blu che ti guardavano da ogni angolo della scrivania. Alla fine siamo rimasti con rettangoli neri e grigi, superfici piatte, design talmente “puliti” da sembrare sterilizzati. Il design industriale in stile Memphis degli anni 80, con i suoi triangoli fucsia e le sue linee assurde, oggi sembra di un’altro pianeta. Ma forse è il contrario: forse siamo noi, adesso, a vivere in un futuro più povero. Più noioso. Più piatto. Che dite?
Quando tutto aveva una faccia
Gli anni 80 erano un carnevale. Il design industriale dell’elettronica consumer era una festa di plastica colorata, pulsanti sporgenti, forme che sfidavano la geometria euclidea. Ettore Sottsass (tre compassi d’oro vinti, dico tre) fondò il gruppo Memphis nel 1981 con un’idea semplice: il minimalismo era noioso. Servivano colori vivaci, forme geometriche audaci, materiali “poveri” come il laminato plastico elevati a dignità estetica. I suoi mobili sembravano costruiti da un bambino dopo una scorpacciata di caramelle. E funzionava.
Nel frattempo, in Italia, Olivetti produceva macchine da scrivere e computer che erano opere d’arte. La Valentine di Ettore Sottsass (ancora lui) del 1969 era rossa come una Ferrari. Portatile. Iconica. Una macchina da scrivere che urlava la sua presenza. La Divisumma 18 di Mario Bellini, calcolatrice del 1973, aveva una tastiera in gomma morbida che sembrava organica. Questi oggetti non cercavano di scomparire. Volevano essere visti.

Negli anni 90 arrivò la trasparenza. L’iMac G3 del 1998, quello turchese con il retro trasparente, diceva: “Guardami. Sono fatto di circuiti e plastica colorata. Non ho paura di mostrarlo”. Le console PlayStation erano grigie ma con forme scultoree. I telefoni Nokia avevano cover intercambiabili. Potevi avere un telefono diverso ogni settimana, se volevi. Il design industriale era una promessa: questo oggetto ha personalità. E tu, usandolo, ne hai di più. E poi?
Poi è arrivato il nero
Il 2007 segna, come detto, lo spartiacque. Steve Jobs sale sul palco del Macworld e presenta l’iPhone. Rettangolo nero. Schermo. Un solo pulsante. Fine. Il design industriale si trasforma in sottrazione matematica: togli pulsanti, togli spessore, togli colore, togli texture. Quello che resta è “eleganza”, è il monolite nero di Odissea nello spazio. E noi improvvisamente, da soggetti con una personalità, sembriamo subito le scimmie che lo circondano: perchè questa eleganza è anche anonimato. L’iPhone funzionava talmente bene che tutti lo copiarono. Non le funzioni, l’estetica. Il dogma divenne: se vuoi sembrare premium, devi sembrare invisibile.
Nel 2019 Don Norman e Bruce Tognazzini, due guru del design che avevano contribuito a creare le linee guida Apple negli anni 80, pubblicarono un articolo devastante. Titolo: How Apple Is Giving Design A Bad Name. Accusavano l’azienda di aver privilegiato l’estetica minimalista sull’usabilità. Icone indistinguibili. Funzioni nascoste dietro menu invisibili. Il “virus del minimalismo” aveva infettato tutto. Era troppo tardi, però.
E non era solo Apple. Google lanciò Material Design nel 2014: superfici piatte, colori primari, ombre minime. Microsoft seguì con Fluent Design. Tutti si votavano allo stesso Santo: la semplicità assoluta. Il problema è che la semplicità, portata all’estremo, diventa uniformità. Prendi uno smartphone del 2025. Toglilo dalla scatola. Senza il logo, non sai se è Samsung, Xiaomi, Oppo o Apple. Stesso rettangolo di vetro. Stesse cornici sottili. Stesso schermo che occupa il 95% della superficie. Il design industriale si è trasformato in una gara a chi riesce a essere più neutro.
La scienza del minimalismo (e i suoi limiti)
Il minimalismo ha basi scientifiche solide. Uno studio del 2023 pubblicato su ResearchGate dimostra che i prodotti con design minimalista sono percepiti come più facili da usare, più affidabili, più “autentici”. I consumatori preferiscono interfacce pulite perché richiedono meno sforzo cognitivo. È vero. Ma c’è un “ma”.
Una ricerca del Journal of Consumer Research del 2022 ha analizzato il “minimalismo del consumatore” identificando tre dimensioni: numero ridotto di possessi, estetica spartana, consumo curato. Il punto è che il minimalismo funziona quando è una scelta personale. Quando diventa l’unica opzione sul mercato, si trasforma in omologazione. Non è più “meno è meglio”. È “meno è l’unico che hai”.
Prendiamo i laptop. Negli anni 90 avevi i ThinkPad neri squadrati, i PowerBook bianchi eleganti, i portatili Toshiba argentati con lo schermo che ruotava. Oggi? MacBook grigio siderale, Dell XPS argentato, ThinkPad nero. Il mio Alienware Aurora è giusto blu scuro, ma siamo lì. Fine. Le differenze sono millimetriche. Letteralmente: si misurano in millimetri di spessore e grammi di peso. Il resto è identico. Tastiera chiclet. Trackpad grande. Cornici sottili. Il design industriale si è ridotto a un esercizio di ottimizzazione, non di espressione.

La storia italiana del design industriale: quando eravamo maestri
L’Italia aveva un rapporto speciale con il design industriale. Non era solo estetica, era filosofia. Achille Castiglioni progettava lampade come la Arco (1962) che erano sculture funzionali. Gio Ponti creava la Superleggera (1957), una sedia che pesava meno di due chili ma reggeva 200 chili. Marco Zanuso e Richard Sapper disegnarono la radio TS 502 per Brionvega nel 1964: un cubo arancione che si apriva come un libro. Non cercava di essere discreta. Voleva essere notata. Era semplicemente meravigliosa, ne sono ancora oggi follemente innamorato.
Anche nell’elettronica consumer. La macchinetta per caffè Gaggia “Carezza” del 1997 aveva forme morbide e colori pastello. Non era “professionale”. Era domestica, calda, umana. Le macchine espresso italiane degli anni 90 erano opere d’arte cromate, non attrezzi da cucina. Poi è arrivata la globalizzazione. E con essa, l’omologazione. Le aziende italiane hanno iniziato a copiare il linguaggio minimal tedesco e quello tech californiano. Risultato: hanno perso la voce.
Oggi Jony Ive, l’ex capo del design Apple, ammette che “all’industria tech manca la gioia”. Parole sue. L’uomo che ha progettato l’iPhone, simbolo supremo del minimalismo, dice che forse abbiamo esagerato. Che la tecnologia dovrebbe rendere felici, non solo efficienti. È un po’ tipo quel collega che dopo anni di dieta rigida ammette: “Forse un cornetto ogni tanto non guastava”. Scommettiamo che tirerà fuori un’altra roba invisibile per OpenAI? Ovviamente spero di perdere.
Design industriale “piatto”: il costo nascosto dell’uniformità
C’è un problema pratico in tutto questo. Quando tutti i prodotti si assomigliano, come scegli? Nel 1998 compravi un iMac perché era turchese e trasparente. Oggi compri un iPhone perché… tutti comprano un iPhone. Il design industriale aveva una funzione di mercato: differenziare. Rendere un prodotto riconoscibile. Creare affezione. Un rettangolo nero non crea affezione. Crea indifferenza.
I produttori lo sanno. Per questo spingono sui “servizi” e gli “ecosistemi”. Non puoi distinguere un telefono dall’altro guardandolo, quindi ti leghiamo con iCloud, Google Photos, Samsung Galaxy Store. Il prodotto fisico è diventato un pretesto per vendere abbonamenti. Il design perde importanza perché il prodotto stesso perde importanza. Quello che conta è la piattaforma.
Ma c’è anche un costo emotivo. Gli oggetti che usiamo ogni giorno raccontano qualcosa di noi. Una radio Memphis degli anni 80 diceva: “Sono eccentrico, mi piace osare”. Un PowerBook bianco del 2000 diceva: “Sono creativo, penso diversamente”. Un iPhone nero del 2025 dice: “Esisto”. Non è poco. Ma non è nemmeno molto. Il rapporto tra persone e oggetti si è raffreddato. Sono strumenti, non compagni. Efficienti, certo. Ma anche tremendamente freddi. Forse è un bene, perchè questa anonimità favorisce il distacco dalla tecnologia? Dimostratemi che succede, io questo distacco non lo vedo. La tecnologia ci controlla, e noi non controlliamo nemmeno l’espressione personale del suo utilizzo.
Torneranno i colori?
Qualche segnale c’è. Apple ha presentato nel 2025 “Liquid Glass”, un nuovo linguaggio di design che reintroduce trasparenze, fluidità, un po’ di colore. Non è una rivoluzione, ma è un passo. Alcuni produttori di cuffie e speaker Bluetooth stanno tornando a forme scultoree e colorazioni vivaci. È poco, ma è qualcosa. Il mercato del retro-gaming è esploso proprio perché la gente ha nostalgia di console che sembravano giocattoli, non monoliti neri.


Il problema è culturale. Il design industriale del 2025 deve confrontarsi con sostenibilità, digitalizzazione, personalizzazione di massa. Tutte cose serie. Ma forse c’è spazio anche per un po’ di leggerezza. Non servono forme assurde o colori psichedelici. Basterebbe che un telefono non sembrasse il clone di tutti gli altri. Che un laptop avesse una maniglia, tipo i vecchi iMac. Che una TV non fosse solo uno schermo nero appoggiato su un supporto nero.
Il design industriale non è morto per vecchiaia. È stato ucciso dalla convinzione che l’eleganza coincida con l’assenza. Che il migliore design sia quello invisibile. Ma forse abbiamo confuso invisibilità con inesistenza. Un oggetto può essere discreto senza essere anonimo. Può essere semplice senza essere banale. Può essere funzionale senza essere freddo.
Il Memphis aveva un motto: “Il design dovrebbe far sorridere”. Non è una filosofia sofisticata. Ma è onesta. E forse, in un mondo di rettangoli grigi, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Un po’ di colore. Un po’ di follia. Un po’ di vita. Il minimalismo ha vinto la battaglia.
Ma non è detto che debba vincere la guerra.